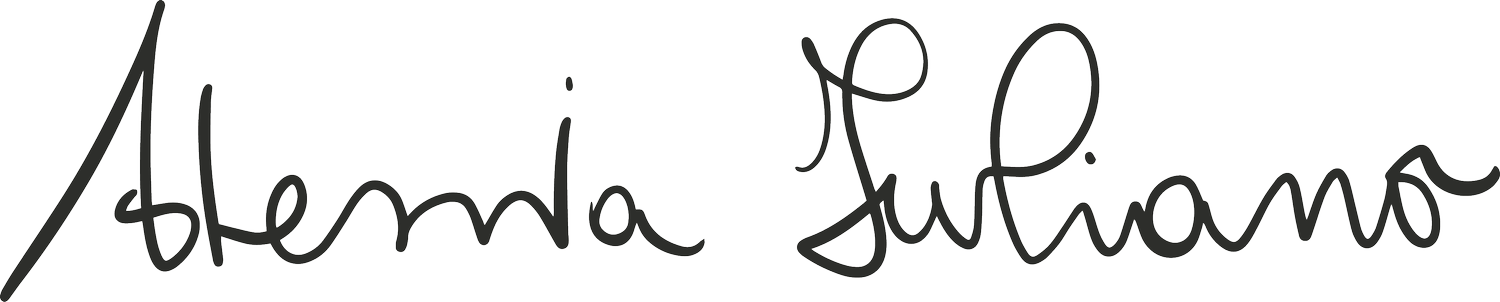Lingua e resistenza: il debutto poetico di Stefania Carminati
Stefania Carminati, Posture. Ciò che distingue dai morti, Nulla Die Edizioni, 2025
di Alessia Iuliano
Nel 2021, all’interno del volume Il posto dello sguardo. Scuola e poesia tra complicità e smarrimenti (Punto a Capo Editrice) - a cura di Corrado Bagnoli, Mauro Ferrari e Alessandro Pertosa - Sebastiano Aglieco firma un intervento che oggi si rivela, se possibile, ancor più attuale. Con lucidità critica, l’autore osserva come la poesia, da lingua viva e originaria, rischi di ridursi a linguaggio funzionale, assoggettato a una logica di produzione e consumo. Si tratta della cosiddetta “poesia ecologica”, depurata da retoriche e posture, ma che spesso finisce per uniformarsi ai temi di tendenza, adattandosi al mercato editoriale e all’orizzonte d’attesa di lettori sempre più frettolosi. Anche il libro di poesia, sottolinea Aglieco, si trasforma così in oggetto transitorio, destinato a una rapida obsolescenza.
In questo scenario, la scrittura poetica sembra oscillare tra due poli opposti: da un lato, la costruzione calcolata di testi “spendibili”; dall’altro, una voce ancora mossa da un’urgenza profonda, capace di oltrepassare la soggettività per restituire il mondo in forma altra. Ma, si domanda Aglieco, quale spazio resta per il lettore? E quale postura può assumere chi nella poesia ricerca una lingua davvero necessaria?
A partire da tali interrogativi — e senza voler forzare il gioco di parole insito nel titolo — si può leggere Posture. Ciò che distingue dai morti, esordio poetico di Stefania Carminati, pubblicato nel luglio 2025 da Nulla Die Edizioni. Una silloge agile — poco più di trenta pagine — ma densa, che rifiuta il minimalismo anodino, fondata su un’urgenza interiore non mimetica né strategica. Il sottotitolo, “ciò che distingue dai morti”, non è un’aggiunta accessoria, bensì una chiara indicazione di poetica: suggerisce che scrivere versi, per l’autrice, rappresenta un gesto di resistenza, un modo per restare vitalmente presenti.
Sin dalle prime pagine emerge un autoritratto netto, talvolta impietoso, che non concede nulla alla semplificazione comunicativa né all’accademismo stilistico oggi dominante. La poesia che apre la raccolta — Di quando ero piccola — ne è esempio emblematico: restituisce un’infanzia attraversata da immagini nitide, taglienti, mai decorative, con una lingua capace di tenere insieme visione e concretezza. Il dolore è assente dal ricordo infantile, ma si riaffaccia nel presente come incrinatura irrimediabile: “Io oggi temo solo cose stupide: / [...] che un’ape involata sui fiori / trovi in me il suo finale”.
La poesia non si propone come enunciazione di verità, ma come ricerca costante di una lingua in grado di sostenere proprio quella tensione lì, tra esperienza e visione.
Due sono i nuclei tematici che attraversano l’opera e ne consentono una precisa collocazione in ambito contemporaneo: la madre e l’infanzia.
La figura materna, individuata da Cinzia Demi come centrale nella poesia femminile degli ultimi decenni (si veda “Uno sguardo alle autrici contemporanee” in L’Anello Critico, CartaCanta, 2023, a cura di G. Lauretano), si affaccia in Posture con tratti originali. Non si tratta di un tributo elegiaco né di mero ricordo affettivo: la madre, nei versi di Carminati, è atto generativo che precede e supera la biologia. È gesto, cura, trasmissione. Come scrive l’autrice: “Per trovare madre saltai un grembo, / tornai seme in mani già anziane”. Una genealogia altra, tutta interna alla sfera simbolica e dell’anima, più che a quella del sangue. La lingua, elevata ma mai artificiosa, riesce a intrecciare delicatezza e forza, rivelando una voce poetica consapevole della propria necessità.
Il secondo asse tematico è quello dell’infanzia, categoria che ha assunto negli ultimi anni un valore simbolico pregnante. Come ha rilevato Davide Rondoni in un intervento qui su Clandestino, molte poetesse oggi costruiscono una figura infantile mitizzata, fiabesca, quasi iniziatica; in questa direzione mi pare collocarsi anche Il passero bianco di Sofia Fiorini (appena uscito per Vallecchi, 25 luglio 2025), presentato da Isabella Leardini come “fiaba iniziatica [...] tra il giardino e il bosco, tra l’infanzia e la sua perdita desiderante e definitiva”.
Posture, pur accostandosi a tale dimensione, se ne distanzia nettamente. L’infanzia qui evocata non è luogo mitico né rifugio salvifico, ma soglia traumatica, il punto in cui la fiaba si infrange. Emblematica, in tal senso, la poesia che recita: “non so dire cosa poi arrestò la fiaba, / se una lingua sconfinandomi / provocò la morte di tutti i maghi”. Qui la fiaba cessa di essere narrazione consolatoria e si fa frattura, contaminazione. L’infanzia è attraversata da vuoti, infezioni, rovine. La bambina non è né eroina né semplice spettatrice, ma per diventare grande attende “schiacciando / il naso sul vetro del forno”, oppure gioca a fingersi ciclope — non è, essa stessa, creatura mitica — e osserva come, guardando con un solo occhio aperto, cambi la prospettiva: “Spiegavi che se gli occhi fanno a turni / cambia come vedi i gradini in selce”.
La materia della poesia di Stefania Carminati è sensibile e in continua trasformazione; è coscienza che attraversa lo schianto, come avviene soprattutto nei versi più taglienti delle parti finali: “oggi io imploro un altro giorno / senza più ridere con fragore”.
Nei suoi versi non si avverte traccia di nostalgia, nemmeno laddove offre — per così dire — “qualcosa che somigli a un conforto”. Piuttosto, ciò che si impone è la rappresentazione di un’esistenza segnata da segni disfatti, da ferite ancora aperte, che tuttavia rivendicano una loro irriducibile sopravvivenza.
“Se ogni uomo è una scuola,
da me si apprenda con lentezza
la postura eretta nel crampo,
il pensiero a lato, l’attesa del termine”
Ciò che colpisce maggiormente è la verità che attraversa questa scrittura: una poesia che nasce da una tensione autentica che non è adesione tematica, ma necessità espressiva. Il linguaggio, visionario e personale, coglie la cesura, la ferita, e la restituisce in forma lirica, senza compiacimenti.
È questo che rende Posture un esordio significativo: non tanto per la maturità del tono o per la cura formale già evidenti — su cui, sono certa, Stefania saprà lavorare bene nel tempo — quanto per il fatto che ogni testo porta con sé una lingua non delegabile, una postura irriducibile. Un modo di stare al mondo che, per riprendere il sottotitolo, davvero “distingue dai morti”.
Testi scelti
Di quando ero piccola ricordo
il racconto, un luogo dalle porte sacre
dove si entrava di corsa.
Ricordo il disegno di mia madre:
griglie in cui i numeri soffocando
dicevano le inique divisioni.
Diventare grandi era come
attendere schiacciando
il naso sul vetro del forno.
Ricordo i giardini e chi ne tagliava
gli alti arbusti perché noi restassimo
i piccoli, e porti stranieri da cui diramavano
chiassi, fossi dove finivano le nostre case.
Di quando ero piccola non ricordo
il dolore, questa spina nell’anca
che chiamano colpo,
gli occhi da cui ogni mattina
strizzo residui dell’incubo,
o la patina fetida sul domani.
Io oggi temo solo cose stupide:
che i troppi morti mi guardino
nuda a sputare sui crocefissi,
la destra e la sinistra prima di
cedere il passo alla strada,
che un’ape involata sui fiori
trovi in me il suo finale.
*
Una mattina che eravamo ancora corte
- le madri per gridare gonfiavano
le guance lisce - noi come bisce
strofinando i sassi ci spingevamo
all’arco del cortile dove dicevi
le storie false di chi è bambino.
Spiegavi che se gli occhi fanno a turni
cambia come vedi i gradini in selce.
Quella mattina che da esile ciclope
alternai lo sguardo, vidi spostarsi
di poco il tabacchi, il forno accanto:
di tutto lo spazio eravamo i motori.
Gli adulti muovevano fatti noiosi
come biglie incagliate in sabbie dure.
Potevamo spezzare il segreto
lasciare che tutto tornasse a farsi
fermo e utile: allora spalancati
gli occhi, la piazza di nuovo al posto
annegava nella luce.
*
Per trovare madre saltai un grembo,
tornai seme in mani già anziane:
così con un gesto deciso di becco
dicendo che un nido non ha lunario
intrecciava rami per il mio risveglio,
come se fossi una sua decisione.
Ed è perché piena della sua anima
che parlo gentile ai viali, alla neve,
da quando nel nido con sforzo
soffiò in me i suoi respiri senili,
così ampi da rendere viva la pietra.
*
Ciò che mi manca ha a che fare con la profondità delle sere, quando il profumo del punto opposto nel mondo – sconfinando – mi raggiungeva per metri di cielo. Ciò che mi manca è una docilità bambina – la pazienza nelle tragedie – come un uragano a soffiare con dolcezza sulle chiome. È un modo di dirsi soli e in ascolto, devoti al fiume del tempo. Ciò che mi mangia è il lutto, la corsa ed il balzo.
Di me rimanga l’inutile invidia per le albe,
per quel trascolorare ritualmente.
Rimangano orme colme di attesa
per i prossimi mutanti cieli:
e quella speranza senza devozione
di esserne stria, o gradazione.
Rimanga di me il rosa di fiori
a segno di prati sfumati in cielo.
E di questa mia ennesima vita
il braccio all’eterno, il mio corpo a stelo.
Nota comparsa per la prima volta su clanDestino